22 febbraio 2008
In Fondo al Fondo
di Antonello Ricci
“Il perché tutte quelle parole si fossero messe a sedé ne la carta, questo, non si sa” (Luciana)
Questa nostra breve storia si svolge tra Cecina e Corneto.
Ma la verità, quella vera, è che non esistono maremme.
E non c’è da perderci troppo tempo.
Poiché, voi ed io lo sappiamo bene, non esistono luoghi.
Se non negli echi del nome che li invoca.
Poiché un paesaggio è solo transito, gesto. Linea di colline. Incrocio di sguardi e strade.
Qualcuno le chiama storie.
E sempre noi (noi uomini, intendo) vogliamo sederci intorno a un fuoco.
E ascoltare.
Ed è in questo che ci riconosciamo.
Questa nostra breve storia, come molte storie, principia con un paradosso.
Perché il suo inizio, in fondo, non è altro che una fine.
Speranze, paure, desideri impiccati a un trave.
Sotto a una luna enorme.
Quel corpo, appeso al prun dell’ombra sua molesta, ha poco più di trent’anni.
Non importa come si chiamasse nel tempo prima di ogni tempo.
Dio fondatore, immemore e inconsapevole.
Strazio, lutto sordo, risentimenti a vuoto. Tortuosi come dedali.
Ma sono faccende che non competono a me.
A me che devo solo raccontare una storia.
Per cui tiro avanti.
E la storia prosegue con una porta che sbatte.
In una sera di vento e stelle.
È il giugno del 2003 (ma potrebbe essere il febbraio di un anno qualunque.
1766. 1896. 1921. 2008).
C’è una bettola, in scena, una fraschetta.
No, un’osteria.
Piantata a un crocchio di strade sulle colline massetane.
Si chiama Pian de’ Mucini.
Potrebbe uscirne gente come Tiburzi e Fioravanti.
Mezzi ’briachi, illuminati dalla brace fioca d’un toscano.
O Chiaro Mori, “Chiarone” l’anarchico, in fuga dai carabinieri.
C’entro io, invece, per presentare il mio libro sui poeti dell’ottava rima.
Fra poco arriveranno Enrico, Bruno, Niccolino (il gran ragionatore in endecasillabi).
Ma c’è già Lio. Lo intravedo dall’uscio. È seduto a un tavolo.
Lio di Pianizzoli.
Lio della Wanda.
Lio poeta gentile e paziente.
Lio cavallaro.
Lio, che già non c’è più.
Ad accogliermi corre Michele, l’oste:
“omo de panza, omo de sostanza”, recita la sua maglietta.
La dieta lo conferma.
La letteratura non è sua “passion predominante”.
Ma quel sorriso e quell’abbraccio, da soli, ti ripagano del viaggio.
(Un giorno Michele cucinerà pesce sul lungomare follonichese.
E allenerà squadre di calcetto femminile.
Ma intanto, dal fondo di quelle campagne, è proprio lui che fonda Il Fondo.
Insieme con Stefano, sia chiaro.)
Eccolo, Stefano, che infila l’uscio di fretta, sbruffando malamente.
Pendola con qui dritto da Siena, dalle colline del Buongoverno.
Dove fotografa matrimoni di zingari, sogni cubani, sedute di laurea.
Eternamente sbarca un lunario da barista.
Stefano, i suoi maglioncini dolcevita sdrucita anni ’80.
Stefano, il suo romanzo memorial-generazionale.
Stefano, Don Giovanni in Maremma e Movimento anni ’70.
Stefano, chissà se quell’editing collettivo lo faremo mai…
Stefano…
Quella sera di vento e stelle infine passa.
La festa, appena cominciata, è già finita.
Dovrei ripartirmene per Viterbo. Ma è già notte fonda.
E poi, questo posto mi piace. Questa gente mi piace.
Me ne resto seduto. Bevo un bicchiere di rosso e aspetto.
Passano giorni. Mesi. Anni.
E quella porta torna a sbattere. Di nuovo. Più volte.
Entra Luciana, coi suoi racconti raccontati.
Novelle che sanno di veglia e di camino, di vicoli e tegami, d’ago e ditale.
Che le scappano così, facilifacili, come la pipì.
Ma misteriosamente necessari, e vicini a un ordine di natura.
Poi entra Alberto, prete spretato, mangiapreti e mangiafascisti, caca-articoli e racconti.
La catana sempre piena di storie libertarie.
Di anarchici inseguiti in capo al mondo, sulla tratta Baires-Potassa. E ritorno.
Poi entra Alessandro l’avvocato. Viene da Roma in treno.
La stazza da bernescante (lo immagino spesso in cioce da pastore).
Gli aforismi alla Flaiano. I suoi praticanti e le sue praticande.
La sua Lazio (da vero burino di Formello).
Poi Dario, il webmaster. C’è e non c’è. Sorride sempre. Non interviene mai.
E ancora Manuela, Corrado, Annalisa, Emiliano, Silvana, Alessandro quell’altro ecc. ecc.
Ciascuno bussa per una sosta.
Presto ripartiranno. Ciascuno per la sua strada.
Ma intanto sono qui, per questa cena-racconto.
Siedono attorno al fuoco. Lo attizzano.
Gli sguardi si rincorrono. Piccoli cenni.
Raccontano a turno. Sennò ascoltano. Soltanto.
Pensavamo che Il Fondo fosse un’associazione. Un gruppo. Una forma, insomma.
Discutevamo, accanendoci, se fosse dibattito o convegno.
E invece era davvero un’osteria.
Un’osteria soltanto, perduta in fondo alle maremme.
Era la sala del banchetto di Alcinoo.
Era Demodoco che canta.
Era Ulisse che piange e vuota il sacco.
Erano le nostre orecchie incredule, pronte ad ascoltare la madre di tutte le storie.
Era la vita.
Erano i tortelli della Wanda.
16 febbraio 2008
Liberarsi dalla mentalità del ghetto
L'Italia è un ghetto, gated community, galera della mente. Negli sguardi il mondo è assente. Provincialismo, campanilismo, familismo, visioni sempre più anguste. Le lingue inciampano sugli idiomi forestieri, i media ufficiali alzano muri, presidiano i confini, fanno entrare in prevalenza fesserie, propaganda, mode effimere e gossip. Dentro, poi, è una nube perenne di gas, "l'onorevole ha dichiarato... il senatore ha detto... la coalizione... le riforme...". Non-eventi, commenti sui commenti, dibattiti dementi. La Rete permette di comunicare col mondo, ma nessuno insegna a usarla al meglio, in modo conscio e responsabile, e anche lì si formano ghetti, énclaves, circuiti di celle di clausura in cui s'amplifica il provincialismo.
Tra gli italiani che vanno all'estero, molti transumano in ulteriori ghetti, villaggi-vacanze, luoghi plasticosi dove si spaparanzano, senza mai conoscere nulla della società che sta intorno, finché attentati o guerre civili non fanno irrompere l'odiata realtà, e allora l'anno prossimo si cambierà destinazione, si troverà una nuova bolla in cui parlare solo italiano, tra italiani, e lamentarsi di come vanno le cose là a casa, inveire contro i negri, gli zingari, i Comuni che lasciano costruire le moschee.
Tra quelli messi peggio c'è persino chi finge di andare in vacanza, saluta i vicini e si chiude in casa, finestre sprangate, scorta di viveri, due-tre settimane modello bunker, poi "torna" con racconti di fantasia.
"Vacanze-talpa", le chiamano. Metafora perfetta, in un paese di politica da talpe, informazione per talpe, incontri tra talpe, vite da talpe.
E il peggio è che ci si abitua. Si abituano anche i migliori, cedono al disincanto, all'abitudine, alla sconfitta. Si china la testa e si va avanti, magari si tira qualche bestemmia ogni tanto, ma non si va oltre. La vita da talpe diventa normalità, corso delle cose. Fuori il mondo collassa e preme, ma le talpe se ne accorgeranno solo all'ultimo momento, quando un disastro interromperà il tran tran. E intanto: centrosinistra, centrodestra, centrosinistra, il PIL cresce dello 0,1%, il PIL cala dello 0,1%, e leggi elettorali chiamate con nomignoli, e la Confindustria dice, e l'onorevole dichiara...
La mentalità del ghetto è il peggior nemico. La mentalità del ghetto ottunde e disarma, distrugge le difese.
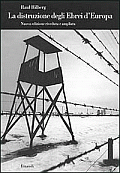 Torna attuale, oggi più che mai, uno scritto di Bruno Bettelheim (1903-1990), celebre e controverso psicologo ebreo. Non è un testo clinico, ma una riflessione storico-politica. Si intitola "Liberarsi della mentalità del ghetto", e chiude la raccolta di saggi La Vienna di Freud (Feltrinelli, 1990).
Torna attuale, oggi più che mai, uno scritto di Bruno Bettelheim (1903-1990), celebre e controverso psicologo ebreo. Non è un testo clinico, ma una riflessione storico-politica. Si intitola "Liberarsi della mentalità del ghetto", e chiude la raccolta di saggi La Vienna di Freud (Feltrinelli, 1990).Bettelheim si interroga sui motivi per cui gli ebrei d'Europa opposero così poca resistenza al loro sterminio, anzi, moltissimi "marciarono consenzienti verso la propria morte", e alcuni addirittura collaborarono con zelo al disegno dei carnefici, ad esempio denunciando i tentativi di evasione dai lager o consegnando alle SS leader della resistenza come Yitzhak Wittenberg. E non si parla di perfidi kapò, ma di vittime, persone avviate alla morte, tanto fatalisticamente rassegnate da vedere nella resistenza altrui un inaccettabile affronto al destino, al corso delle cose. "Si comportavano così", scrive Bettelheim, "perché avevano rinunciato alla volontà di vivere e si erano lasciati invadere dalle loro tendenze distruttive. Di conseguenza, ormai si identificavano con le SS, che si erano poste al servizio di tali tendenze, più che con i compagni che ancora rimanevano attaccati alla vita, e che per questo riuscirono a eludere la morte."
Bettelheim parte da una constatazione di Raul Hilberg sul "ruolo che gli ebrei ebbero nel proprio sterminio", cita diversi episodi, e da essi risale al comune denominatore: la mentalità del ghetto (ghetto thinking). Furono la chiusura mentale delle comunità ebraiche (soprattutto dell'Europa orientale), il loro asfissiante conformismo, l'obbedienza al dogma religioso e la costante fuga dal mondo a impedire di capire per tempo cosa stava per accadere, quando invece era evidente a chiunque altro, in primis agli ebrei che avevano lasciato i ghetti e tagliato i ponti e si erano messi al riparo prima del punto di non-ritorno.
A scanso di equivoci: non sto aderendo alla tesi di Bettelheim (e Hilberg), che ha scatenato polemiche e accuse postume. In generale mi suona plausibile, gli esempi sono numerosi e mi è parso di trovare conferme negli studi di altri autori. E' vero tuttavia che Primo Levi, nel capitolo "Stereotipi" de I sommersi e i salvati, imposta la questione in modo molto diverso. Se mi azzardassi ad approfondire finirei fuori strada e nel mezzo di un ginepraio; lascio dunque a chi legge la libertà di confrontare i due punti di vista e trarre le proprie conclusioni.
Non intendo nemmeno operare una reductio ad hitlerum. Paragonare qualunque crisi sociale a quella che portò al nazismo e alla Shoah è uno sport fin troppo - e sempre più - praticato. Non coltivo l'osceno proposito di stabilire similitudini tra le "forze sane" (o sanabili) di questo Paese e gli ebrei sterminati nei campi. Chiunque di noi è sideralmente lontano dal subire alcunché del genere.
Quel che mi interessa è il "ghetto" come metafora utile a capire la situazione italiana, con particolare riferimento a due fenomeni interdipendenti: la "fuga dei cervelli" e il restringersi degli orizzonti. Scrive infatti Bettelheim:
Per almeno tre generazioni, tutti coloro che non erano più disposti a sottomettersi a condizioni di vita che non consentivano il minimo di rispetto di sé necessario a confrontarsi col mondo moderno, se ne andarono dal ghetto. Così come se ne andarono tutti coloro che di quel mondo volevano fare parte e tutti coloro che volevano combattere per la libertà, propria e altrui [...] E' difficile valutare quali effetti abbia su un popolo il fatto che per tre generazioni i suoi membri più attivi, quelli il cui ideale era combattere per la libertà, se ne siano andati, e siano rimasti soltanto quelli a cui mancano il coraggio e l'immaginazione per concepire un modo di vivere diverso. Il piccolo gruppo di ebrei che tanto si distingue nella vita culturale americana, per esempio, si era allontanato da almeno un secolo dalle comunità ebraiche dell'Europa orientale.
Ci sono due modi di andare oltre la mentalità del ghetto.
 Il primo consiste appunto nel sottrarvisi. Esodo, emigrazione. Per fare un esempio, l'Italia ha un mondo accademico che aborre il ricambio e sfrutta, umilia, devasta dottorandi e ricercatori. I concorsi sono truccati, i posti sono bloccati, nemmeno leccare culi dà più garanzia di alcunché.
Il primo consiste appunto nel sottrarvisi. Esodo, emigrazione. Per fare un esempio, l'Italia ha un mondo accademico che aborre il ricambio e sfrutta, umilia, devasta dottorandi e ricercatori. I concorsi sono truccati, i posti sono bloccati, nemmeno leccare culi dà più garanzia di alcunché.Andarsene all'estero è un'opzione giusta, perché libera gli individui e sprigiona energie, ma a lungo termine le conseguenze sul luogo abbandonato possono essere molto negative, se non catastrofiche. Con il brain drain il panorama culturale italiano si impoverisce, cala il numero di sinapsi attive, il livello medio si abbassa sempre di più.
Si potrebbe riporre qualche speranza negli immigrati, o meglio, nel desiderio dei loro figli e nipoti di abbandonare i nuovi ghetti, le ennesime gated communities, le isole di conformismo e paranoia, ma non ci riusciranno se la situazione del Paese continua a peggiorare. Il circolo è vizioso.
L'altro modo è sfumare la distinzione fra chi parte e chi rimane, creando intersezioni, figure ed esperienze di sintesi, e soprattutto circoli virtuosi.
Da un lato, chi se ne va e riesce a lavorare bene dovrebbe compiere ogni sforzo per avere un'influenza positiva sulla situazione che si è lasciato alle spalle.
Dall'altro, ed è questo l'aspetto più importante, chi rimane deve contrastare le spinte alla chiusura, resistere a provincialismi e nuovi razzismi, guardare fuori e cercare di guardare l'Italia da fuori, con occhi non velati dalla pigrizia, senza dare niente per scontato o "naturale". Sforzarsi di studiare le lingue, "pensare extra-italiano", auto-educarsi a un uso della rete e delle reti che proietti l'immaginazione oltre le obsolete frontiere nazionali. Chi ha la possibilità di farlo deve tenere un piede fuori dall'Italia, spostarsi, viaggiare, fare periodi di lavoro e studio all'estero, approfittare di ogni progetto, partenariato, stage, borsa di studio, Erasmus, Leonardo, Comenius, quel cazzo che vi pare ma fatelo, andateci.
[NOTA BENE. Uno dei sintomi più evidenti della chiusura italiana è proprio il fatto che, dall'anno accademico 2003-2004, il numero degli universitari che effettuano soggiorni Erasmus è in calo anziché in crescita. Nel 2006, soltanto un misero 6,2% degli iscritti agli atenei italiani ha preso parte al programma. Questa percentuale esprime la media nazionale: la situazione al Nord è leggermente migliore (7,1%), mentre al Sud è decisamente peggiore (3,5%).
E' vero, c'è un problema di classe sociale, le borse di studio di cui parliamo ammontano a cifre ridicole e non bastano al sostentamento dello studente, quindi chi viene da una famiglia o da una zona più povera ha maggiori ostacoli di fronte a sé... ma questo era vero anche prima, è sempre stato vero, di per sé non basta a spiegare un simile rattrappimento. Anche perché parliamo del 94% degli universitari italiani, cioè - nell'anno accademico 2005-2006 - oltre duecentottantamila persone. Ritengo improbabile che siano tutti figli di poveri.
No, il punto è un altro: conosco persone che hanno fatto l'Erasmus negli anni Novanta, da studenti-lavoratori, lavando piatti in ristoranti tedeschi o distribuendo volantini a Londra, di fronte alle fermate del Tube. Io stesso mi sono pagato il Leonardo in Inghilterra facendo lavori improbabili. Se uno desidera andare all'estero ci va anche facendosi il culo. Se non ci si va è perché quell'opzione non è più nell'orizzonte, non viene presa in considerazione, costa troppa fatica mentale. Il problema è culturale, il Paese si imbozzola nell'abitudine, vinto, impaurito.]
 Ripropongo il duro monito di Bettelheim, che risale al 1962 ma sembra scritto domani:
Ripropongo il duro monito di Bettelheim, che risale al 1962 ma sembra scritto domani:Per molti versi, il mondo occidentale stesso sembra avviato ad abbracciare la filosofia di vita del ghetto: non voler sapere, non voler capire che cosa accade nel resto del mondo. Se non stiamo attenti, l'Occidente dei bianchi, che già costituisce una minoranza, si murerà in un ghetto di sua stessa creazione, fatto dei cosiddetti deterrenti nucleari. Molti, dentro tale cintura di protezione, che è anche una cintura di costrizione, già si preparano a scavarsi i loro rifugi. Come per gli ebrei che restarono nei ghetti d'Europa anche dopo l'arrivo dei nazisti, si direbbe che per noi conti soltanto poter continuare il lavoro nel nostro enorme shtetl, e che importa ciò che succede nel resto del mondo?
Occupiamoci del mondo, allora, perché noi siamo il mondo. Vanno bene anche piccoli "esercizi spirituali", giochi per forzare l'immaginazione e corteggiare l'inatteso, come leggere ogni tanto
 un quotidiano giamaicano, o
un quotidiano giamaicano, o  del Belize, o
del Belize, o  della Guinea. Ricordarsi che ci sono tante e diverse comunità di umani, là fuori, tanti mondi, tanti piani di realtà.
della Guinea. Ricordarsi che ci sono tante e diverse comunità di umani, là fuori, tanti mondi, tanti piani di realtà.Senza questo, tutto diventa merda: il sociale, la politica, le arti... persino l'amore, perché anche la famiglia diviene un fortino armato contro l'esterno, tana di talpe dove i "cazzi nostri" contano più di tutto, e a tutto si è disposti per difenderne il primato.
Come hanno fatto Olindo Romano e Rosa Bazzi, perfetta coppia di arci-italiani.
Perché un intero paese non si riduca come loro, guardiamo al di là dei nostri nasi.
Wu Ming 1 www.wumingfundation.com
01 febbraio 2008
Ballarò, Calabresi e Pinelli
Testimonianza di Pasquale Valitutti
 [La settimana scorsa è andato in onda su Rai Tre un "Ballarò speciale" che aveva tra i protagonisti Mario Calabresi, corrispondente da New York de La Repubblica, figlio del commissario Luigi Calabresi e autore del libro di grande successo Spingendo la notte più in là, Mondadori, 2007. Posto che è giusto che un figlio difenda la memoria del padre, certe affermazioni, come quella relativa all'assenza di Luigi Calabresi dalla stanza da cui cadde, il 15 dicembre 1969, il ferroviere anarchico Giuseppe Pinelli - incolpato della strage di Piazza Fontana, di cui era innocente - sono più controverse di quanto la trasmissione facesse trasparire. Ecco, per esempio, la testimonianza resa a suo tempo dall'anarchico Pasquale Valitutti, arrestato con Pinelli. Alcune considerazioni in appendice.] (V.E.)
[La settimana scorsa è andato in onda su Rai Tre un "Ballarò speciale" che aveva tra i protagonisti Mario Calabresi, corrispondente da New York de La Repubblica, figlio del commissario Luigi Calabresi e autore del libro di grande successo Spingendo la notte più in là, Mondadori, 2007. Posto che è giusto che un figlio difenda la memoria del padre, certe affermazioni, come quella relativa all'assenza di Luigi Calabresi dalla stanza da cui cadde, il 15 dicembre 1969, il ferroviere anarchico Giuseppe Pinelli - incolpato della strage di Piazza Fontana, di cui era innocente - sono più controverse di quanto la trasmissione facesse trasparire. Ecco, per esempio, la testimonianza resa a suo tempo dall'anarchico Pasquale Valitutti, arrestato con Pinelli. Alcune considerazioni in appendice.] (V.E.)
Io sottoscritto Pasquale Valitutti dichiaro che: giunto in questura all'ufficio politico verso le ore 11 di sabato 13 dicembre, sono rimasto due o tre ore in sala d'attesa. Spostato quindi nel salone seguente quello dove vi è la macchina del caffè ho visto Pinelli seduto vicino ad Eliane Vincileone.
In seguito, da informazioni datemi da Sergio Ardau e dallo stesso Pinelli ho saputo che Pinelli era stato fermato venerdì sera e interrogato lungamente nella stessa serata di venerdì. Nella notte di venerdì non aveva dormito. Pinelli mi è parso seccato e stanco, ma in condizioni normali. Mi ha parlato del suo alibi e mi è apparso sicuro. Più tardi gli è stata fatta una sfuriata da parte di un agente, che saprei riconoscere, perché aveva gettato della cenere per terra (numerosi i testimoni) e lui si è chinato a raccoglierla.
Più tardi, a sera inoltrata, per ordine di Calabresi siamo stati divisi nella stanza in tavoli diversi, mentre Pinelli e Moi sono stati fatti mettere nella stanza del caffè.
Verso le 24 sono stati fatti andare via tutti gli altri e siamo rimasti io, l'Eliane e Lorenzo. In seguito io e Lorenzo siamo stati portati in cella di sicurezza: non ho più visto Pinelli fino alla domenica dopo pranzo, mi ha detto che lo avevano interrogato la notte di sabato e fatto riposare qualche ora in camera di sicurezza nella giornata di domenica. Nel frattempo io ero stato interrogato e mi avevano portato nel mio abbaino per una perquisizione. Domenica pomeriggio ho parlato con Pino e con Eliane e Pino mi ha detto che facevano difficoltà per il suo alibi, del quale si mostrava sicurissimo. Mi ha anche detto di sentirsi perseguitato da Calabresi e che aveva paura di perdere il posto alle ferrovie. Verso sera un funzionario si è arrabbiato perché parlavo con gli altri e mi ha fatto mettere nella segreteria che è adiacente all'ufficio del Pagnozzi: ho avuto occasione di cogliere alcuni brani degli ordini che Pagnozzi lasciava ai suoi inferiori per la notte. Dai brani colti posso affermare che ha detto di riservare al Pinelli un trattamento speciale, di non farlo dormire e di tenerlo sotto pressione tutta la notte. Di notte il Pinelli è stato portato in un'altra stanza e la mattina mi ha detto di essere molto stanco, che non lo avevavo fatto dormire e che continuavano a ripetergli che il suo alibi era falso. Mi è parso molto amareggiato. Siamo rimasti tutti il giorno nella stessa stanza, quella del caffè e abbiamo potuto scambiare solo alcune frasi, comunque molto signicative. Io gli ho detto: "Pino, perché ce l'hanno con noi?" e lui molto amareggiato mi ha detto: "Si, ce l'hanno con me". Sempre nella serata di lunedì gli ho chiesto se avesse firmato dei verbali e lui mi ha detto di no. Verso le otto è stato portato via e quando ho chiesto ad una guarda dove fosse mi ha risposto che era andato a casa. Io pensavo che stesse per toccare a me di subire l'interrogatorio, certamente il più pesante di quelli avvenuti fino ad allora: avevo quasta precisa impressione.
Dopo un po', penso verso le 11.30, ho sentito dei rumori sospetti come di una rissa e ho pensato che Pinelli fosse ancora li e che lo stessero picchiando. Dopo un po' di tempo c'è stato il cambio di guardia, cioè la sostituzione del piantone di turno fino a mezzanotte. Poco dopo ho sentito come delle sedie smosse ed ho visto gente che correva nel corridoio verso l'uscita, gridando "si è gettato". Alle mie domande hanno risposto che si era gettato il Pinelli; mi hanno anche detto che hanno cercato di trattenerlo ma non vi sono riusciti. Calabresi mi ha detto che stavano parlando scherzosamente del Pietro Valpreda, facendomi chiaramente capire che era nella stanza nel momento in cui Pinelli cascò. Inoltre mi hanno detto che Pinelli era un delinquente, aveva le mani in pasta dappertutto e sapeva molte cose degli attentati del 25 aprile. Queste cose mi sono state dette da Panessa e Calabresi mentre altri poliziotti mi tenevano fermo su una sedia pochi minuti dopo il fatto di Pinelli. Specifico inoltre che dalla posizione in cui mi trovavo potevo vedere con chiarezza il pezzo di corridoio che Calabresi avrebbe dovuto necessariamente percorrere per recarsi nello studio del dottor Allegra e che nei minuti precedenti il fatto Calabresi non è assolutamente passato per quel pezzo di corridoio.
[Perché alla testimonianza di Valitutti - ribadita anche di recente dallo stesso Valitutti in un intervento al centro sociale Leoncavallo di Milano, non fu dato peso? In sede processuale fu contrastata da quelle degli altri poliziotti presenti nell'ufficio di Luigi Calabresi: non esattamente testi "neutri", e tuttavia dotati di un peso istituzionale che un semplice anarchico non poteva avere.
Sia questi poliziotti che il commissario Calabresi sostennero, finché fu possibile, che Pinelli si era suicidato, gettandosi dalla finestra al grido di "E' morta l'anarchia!". In pratica un'ammissione di colpa.
Uno dei poliziotti disse persino di avere cercato di trattenerlo, e che una scarpa gli era rimasta in mano. Versione che dovette essere ritrattata quando si scoprì che Pinelli aveva tutte e due le scarpe ai piedi; che era caduto non per un salto, ma rasente alla parete, rimbalzando addirittura sul frontone; e, infine, quando risultò chiaro che era perfettamente innocente.
Al processo il giudice D'Ambrosio concluse per una morte da "malore attivo". Prendiamo la versione per buona (sorvolando sul fatto che Pinelli era basso di statura, e che la balaustra della questura di Milano era più alta del suo baricentro; per cui uno svenimento non sarebbe bastato a squilibrarlo).
Proprio il "malore attivo" inficia una delle tesi di Mario Calabresi a favore del padre. Mario Calabresi dice che il commissario Luigi e Pinelli erano quasi amici, si scambiavano libri.
Be', una certa familiarità poteva instaurarsi, a quei tempi, tra forze dell'ordine e contestatori. Però dovette essere una ben strana amicizia, se l' "amico" poliziotto trattenne (per affetto?) illegalmente un innocente per tre giorni, se fu l'ultimo a interrogarlo, e se il "malore attivo" si manifestò immediatamente dopo. Secondo D'Ambrosio il misterioso malore fu dovuto al prolungato digiuno, alla mancanza di sonno e alle troppe sigarette fumate a stomaco vuoto. Ma come? L'amico Calabresi teneva a digiuno il suo vecchio compare?
Mario Calabresi dice che il padre fu il capro espiatorio scelto dai superiori. Può darsi, non è difficile credergli. E senz'altro fu un ingranaggio di un sistema. Ciò lo rese bersaglio di un delitto ingiustificabile.
Ma Mario Calabresi si spinge oltre, accusando di complicità oggettiva una serie di intellettuali, da Dario Fo, a Umberto Eco, ad Alberto Moravia, a Elio Petri. Nella trasmissione è stato omesso un nome, quello di Camilla Cederna. Accorsa sul luogo in cui si sfracellò Pinelli e tra le prime a contestare la versione fornita dalla polizia. Autrice di un libro, Una finestra sulla strage, oggi scomodissimo. Non è "militante" quanto la controinchiesta La strage di Stato, ma proprio per questo ebbe peso maggiore nell'ambito culturale italiano.
Quanto alla campagna di Lotta Continua contro Calabresi (il commissario), fu forsennata perché eccessivamente personalizzata. Grave vizio di LC e di altri groupuscules, come la Gauche Proletarienne in Francia. Tuttavia forse cercava di spezzare l'immunità totale di cui gode da sempre, in questo paese, chi uccida o conduca alla morte un militante di sinistra. Potrei partire dai braccianti di Avola e Battipaglia, ma chi li ricorda più? Mi limito a dire che, negli anni di piombo, le vittime del terrorismo di sinistra furono circa 130. I colpevoli furono colpiti con ogni rigore. Invece i militanti di sinistra uccisi - includendo terroristi, non terroristi, gente che non c'entrava nulla - furono una sessantina. Nessuno di coloro che li uccisero è mai stato punito. E qui tralascio le varie stragi, da Piazza Fontana in poi. E le violenze sui no global di Genova o Napoli.
Spero in un futuro "Ballarò Speciale" che intervisti le figlie di Giuseppe Pinelli, ferroviere anarchico, innocente delle accuse, trattenuto illegalmente in questura dal suo amico Calabresi, colto da "malore attivo", caduto come un peso morto da una balaustra che gli arrivava quasi al petto.
Spero, ma una vocina mi dice che un "Ballarò" così non lo faranno mai.] (V.E.)
www.carmillaonline.com